alla fine dell’anno più caldo dell’umanità… finora
Il mondo – la sua politica, la sua economia e il suo giornalismo – ha difficoltà a far fronte alla portata della crisi climatica. Non riusciamo a capirlo collettivamente, cosa che non mi è mai stata così chiara come in questi giorni di fine 2023.
Perché la cosa più importante accaduta quest’anno è stato il caldo. Di gran lunga. Ha fatto più caldo di quanto lo sia stato negli ultimi 125.000 anni su questo pianeta. Ogni mese da maggio è stato il più caldo mai registrato. Le temperature dell’oceano stabiliscono un nuovo record storico, quasi 38 gradi Celsius. Il Canada bruciava, riempiendo di fumo l’aria sopra le nostre città.
Eppure non lo direste davvero, leggendo i riassunti delle notizie dell’anno che ora appaiono su un sito web dopo l’altro.
L’altro ieri, ad esempio, il Times ha pubblicato un saggio del banchiere d’investimento e consigliere di Obama Steven Rattner su “dieci grafici che hanno contato nel 2023”. Questa è la voce più istituzionale che si possa immaginare, nel luogo più istituzionale. E la curva della temperatura globale è entrata nella lista, al numero 10, ben dietro ai grafici sul calo dell’inflazione, sui livelli di approvazione del presidente, sul numero di incriminazioni per Trump, sull’aumento degli immigrati e sulla velocità con la defenestrazione del GOP (repubblicano, ndr) Kevin McCarthy.
In effetti, tre giorni fa il Times e il Post hanno entrambi pubblicato ottimi articoli sulle temperature record del 2023, ma erano strani: in ogni caso, si concentravano sul fatto se l’anno fosse stato sufficiente per dimostrare che la crisi climatica stava “accelerando”. È una domanda interessante, che si basa principalmente su un nuovo potente articolo di James Hansen (uno di cui i lettori di questa newsletter hanno scoperto lo scorso inverno), ma la premessa del rapporto, se si fa un passo indietro, è un po’ folle. Perché la crisi climatica si sta già abbattendo su di noi. Non è necessario che l’“accelerazione” sia il più grande dilemma, per ordine di grandezza, che la nostra specie si trova ad affrontare.
Questo è il problema
In un certo senso, però, è questo il problema. Quelle storie sul Times e sul Post erano un modo per cercare una nuova prospettiva per una storia che non cambia abbastanza velocemente da poter essere considerata una notizia. (In termini geologici, ci stiamo riscaldando a un ritmo infernale; ma non è così che funziona il ciclo di notizie 24 ore su 24, 7 giorni su 7.) Sono mesi ormai che fa caldo a livello mondiale ogni giorno: i primi di quei giorni hanno avuto una certa copertura, ma a un certo punto gli editori, e poi i lettori, cominciano a disconnettersi. Siamo programmati – dall’evoluzione, senza dubbio, e nel caso del giornalismo dal conteggio dei clic – a cercare novità e conflitti. Il cambiamento climatico sembra inesorabile, il che è l’opposto di come pensiamo alle notizie.
La guerra a Gaza, al contrario, si adatta perfettamente alle nostre definizioni. È una tragedia straordinaria, cambia giorno dopo giorno, ed è la definizione di conflitto. E forse c’è qualcosa che possiamo fare al riguardo (motivo per cui molti di noi hanno cercato di creare sostegno per un cessate il fuoco). Quindi, giustamente, attira la nostra attenzione. Ma in un certo senso è proprio la familiarità della guerra che ci rende facile concentrarci su di essa; Il “conflitto medioorientale”, come “l’inflazione” o le “elezioni presidenziali”, è un modello facilmente accessibile nella nostra mente. Le immagini dell’orrore ci mettono, come dovrebbero, a disagio, ma è un disagio familiare. Anche la disperazione e la risolutezza che proviamo ci sono familiari; anche le sottoparti della storia si inseriscono in ritmi familiari (un lettore del New York Times sarebbe perdonato se pensasse che il fronte principale della guerra si stia svolgendo ad Harvard Yard, tra sostenitori della libertà di parola e guerrieri della cultura dell’annullamento). Il prossimo anno sembra essere un’altra orgia di familiarità: Joe Biden e Donald Trump, ancora una volta.
I cambiamenti non si adattano ai nostri modelli semplici
Il cambiamento climatico ha i suoi solchi familiari, soprattutto la lotta con l’industria dei combustibili fossili, che si è ripetuta alla COP 28 di Dubai. Ma gran parte della storia è in realtà nuova di zecca: come ha dimostrato quest’anno, siamo letteralmente in un territorio inesplorato, alle prese con temperature che nessuna società umana ha mai affrontato prima. E per evitare il peggio, avremo bisogno di una transizione industriale su una scala mai vista prima: quest’anno ci sono stati segnali che quella transizione era iniziata (a metà estate stavamo installando un gigawatt di pannelli solari al giorno), ma dovrà andare molto, molto più velocemente.
Questi cambiamenti – quelli fisici, politici ed economici – sono quasi inconcepibili per noi. Questo è il punto: non si adattano ai nostri modelli semplici.
Quanti altri anni come questo dobbiamo ancora avere, per capire?
E lo scopo di questa newsletter, ora e negli anni a venire, è cercare di spiegare la velocità della nostra crisi e spiegare cosa impone sulla velocità della nostra risposta. È una storia che cerco di mettere in prospettiva ormai da 35 anni (La fine della natura è stato pubblicato nel 1989, il primo libro su questa crisi) e continuerò a cercare nuovi modi per affrontarla. Come dice lo scienziato del clima Andrew Dessler, mettilo in un resoconto di fine anno: “L’unica domanda veramente importante è: Quanti altri anni come questo dobbiamo avere prima che la realtà di quanto grave sia il cambiamento climatico irrompa nella coscienza del pubblico?‘”.
Grazie per essere parte di questo sforzo continuo per entrare in quella coscienza e… beh, felice anno nuovo. Sta arrivando da noi, tanto vale far sì che conti.


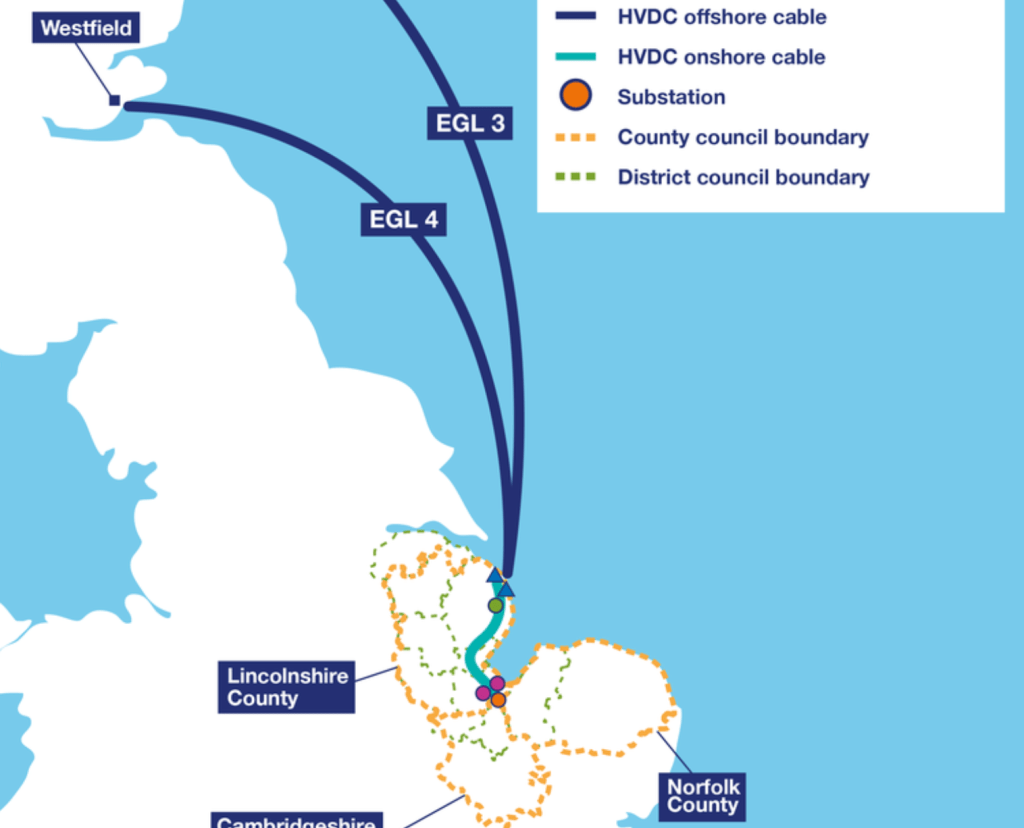



Lascia un commento